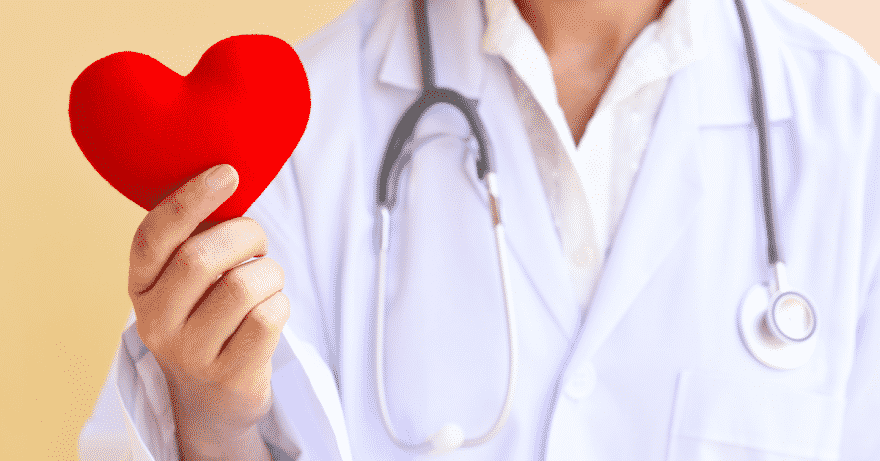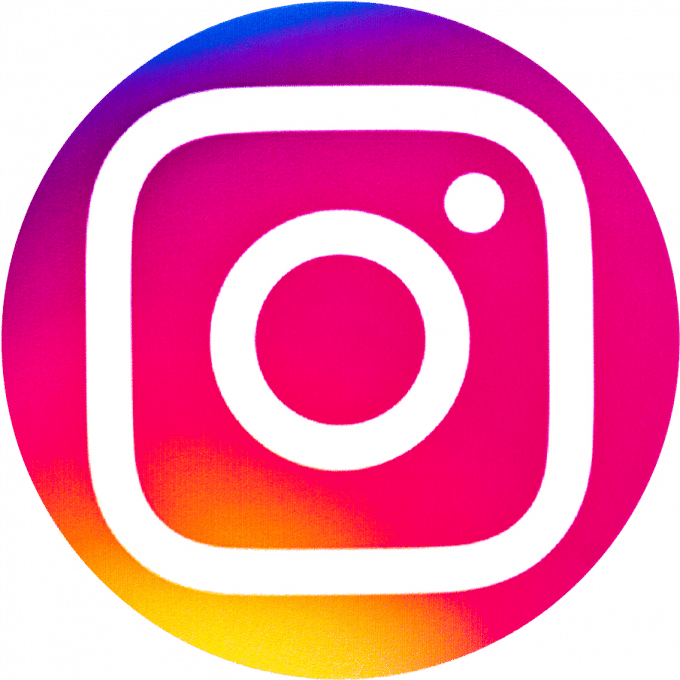Analisi dello studio pubblicato dalla rivista di politica sanitaria “Health Affairs”
Essere pagati per andare dalla medico. Oppure per sostenere visite e esami di carattere preventivo. Quello che oggi, messo in questi termini, potrebbe sembrare irrealizzabile o quanto meno utopistico, un domani potrebbe anche diventare realtà. Con obiettivi di fondo diversi a seconda del contesto in cui si applicherebbe questa sorta di “incentivo alla salute”. Nei Paesi in via di sviluppo, dove paradossalmente queste politiche (in particolare in America Latina) vengono già perseguite, l’intenzione è anche quella di spezzare la catena di povertà che condanna determinate fasce della popolazione a non uscire mai dalla propria condizione di indigenza. Nei Paesi occidentali, invece, il tema è un altro: attraverso la prevenzione (in parte sussidiata dallo Stato) si punterebbe a evitare l’insorgere di malattie che costerebbero poi allo Stato stesso, in termini di cure, somme decisamente più elevate. Insomma, la prevenzione – un tema molto importante per Assidai – promossa con un duplice obiettivo: tutelare la salute dei singoli cittadini e preservare la sostenibilità finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale, già messo a dura prova dal graduale invecchiamento della popolazione e dalle costanti ristrettezze dei bilanci pubblici.
L’esperimento di New York: incentivi per le famiglie a basso reddito
In questo quadro si colloca un interessante studio, pubblicato recentemente dalla rivista di politica sanitaria “Health Affairs” e coordinato dall’Imperial College di Londra, che in sostanza ha testato il modello degli incentivi sanitari su 2.377 famiglie a basso reddito di New York (l’80.9% monoreddito e praticamente tutte ispaniche o di colore), alle quali per tre anni sono stati corrisposti poco meno di settemila euro. La condizione per ricevere questa somma era quella di garantire per sé e per i propri familiari la frequenza scolastica, l’utilizzo dei servizi sanitari a scopo preventivo (vaccinazioni) e l’impegno dal punto di vista lavorativo da parte dei genitori.
I risultati? Molto interessanti. Innanzitutto – elaborando un confronto statistico con un “gruppo di controllo” di altre 2.377 famiglie a basso reddito della Grande Mela che non hanno goduto degli incentivi – emerge un maggior ricorso alla prevenzione; in secondo luogo, tra gli adulti è migliorata la percezione di essere in salute; infine, aspetto non secondario, sempre tra i genitori c’è un’accresciuta speranza di migliorare la propria condizione finanziaria e sociale. Insomma, è la dimostrazione che il modello degli incentivi alla salute può essere esportato anche nei Paesi occidentali, anche se dallo studio su New York emergono riscontri più deboli rispetto a quelli ottenuti in alcuni Paesi dell’America Latina.
La rinuncia alle cure, anche in Italia
A spiccare, in particolare, è il significativo miglioramento nell’accesso alle cure dentistiche e odontoiatriche, che come risultato del programma sono aumentate tra l’11% e il 14%. Un elemento da non sottovalutare visto che negli Stati Uniti sono una delle cure a cui si rinuncia più spesso (in particolare per quanto riguarda i bambini) considerati i costi elevati della sanità privata in quella nazione.
Va ricordato, sempre nell’ottica di un’eventuale applicazione di questo modello nei Paesi industrializzati, che il fenomeno della rinuncia alle cure si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, soprattutto per quanto riguarda accertamenti diagnostici e cure odontoiatriche. Prestazioni, quest’ultime, che evidentemente non vengono percepite come indispensabili, perlomeno nell’immediato, quando una famiglia deve fare i conti con le ristrettezze economiche.
Gli ultimi rapporti eleaborati dal Censis sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata rivelano che nel 2017 sono stati 12,2 milioni gli italiani che hanno rinunciato a una prestazione sanitaria (o l’hanno rinviata) per ragioni economiche: 1,2 milioni in più, ovvero il 10,9%, rispetto al 2016. Secondo queste ricerche, “si tratta ormai di un comportamento stabile, consolidato e ordinario delle famiglie italiane, una sorta di sanità negata non più eccezionale o legata a difficoltà congiunturali, ma stabilmente presente nella società, i cui effetti nel lungo periodo potrebbero toccare lo stato di salute medio dei cittadini”. Un motivo in più, stante la situazione attuale, per guardare con interesse all’ipotesi degli incentivi alla sanità in termini di prevenzione.