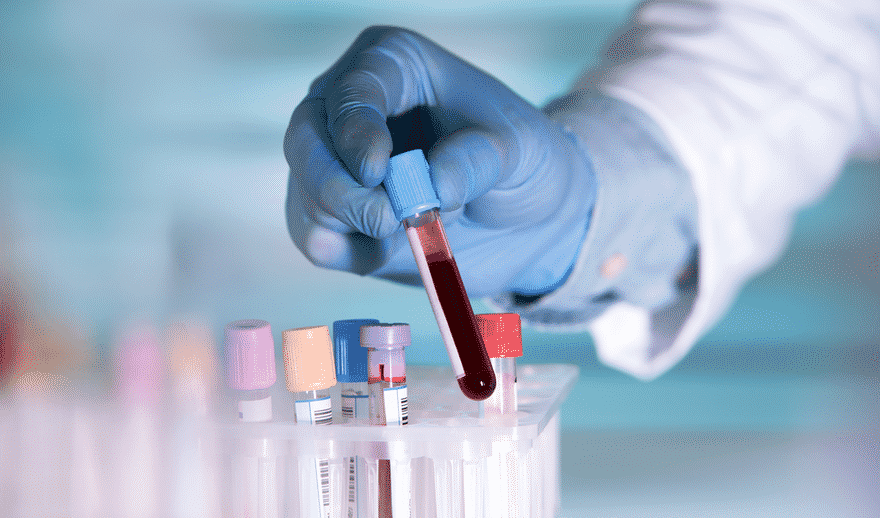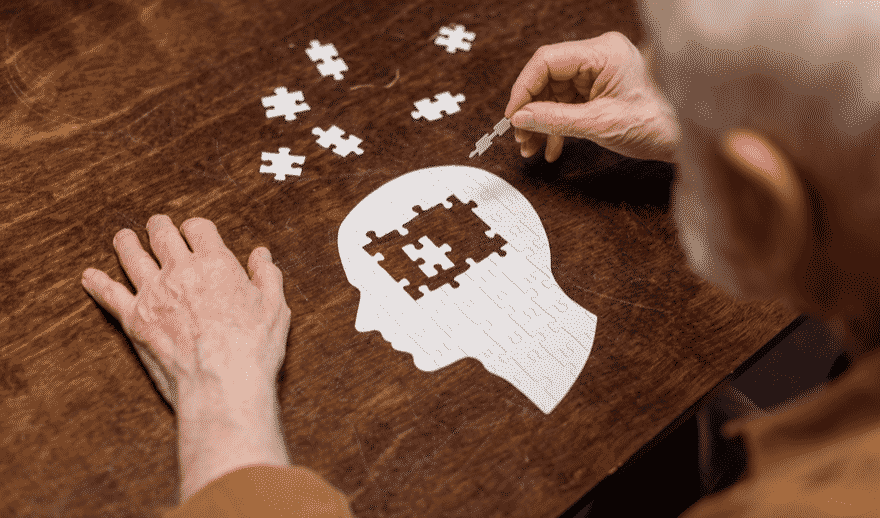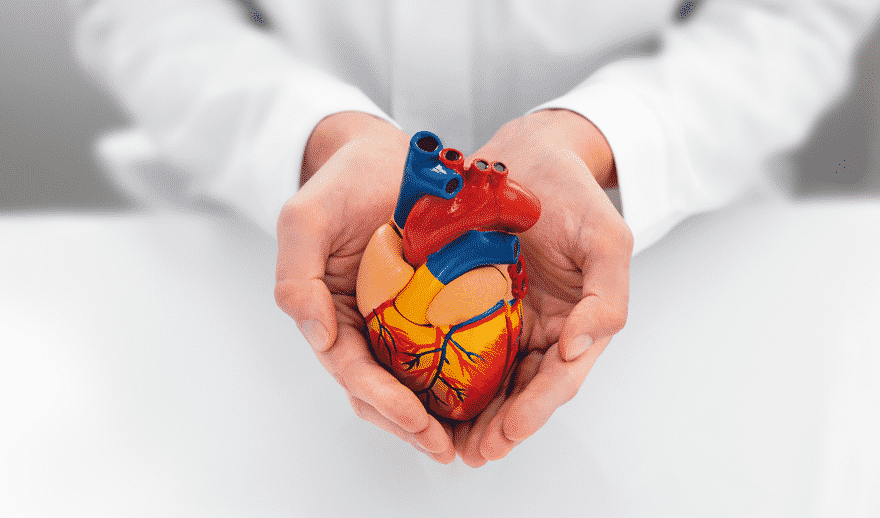“Per troppi anni la sanità è stata considerata un costo e non un investimento. Oggi, con le risorse ordinarie, in due anni e mezzo il Fondo sanitario nazionale è passato da 114 miliardi a 124 miliardi”. È con questa frase che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha recentemente annunciato quella che dovrà rappresentare una svolta duratura e strutturale per la sanità italiana. Insomma, abbiamo davanti a noi, “una grande occasione per capire che si deve e si può costruire un Servizio sanitario nazionale più forte e più capace di rispondere alle esigenze delle persone”.
Un cambio di passo per la sanità e il Paese
Prendendo spunto dagli investimenti straordinari legati al Covid, le prossime politiche di bilancio nei confronti della sanità – secondo il Ministro – non dovranno più prevedere tagli lineari e austerità. “In passato si investiva mediamente 1 miliardo in più all’anno. In due anni e qualche mese abbiamo investito 10 miliardi in più e poi ci sono i 20 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)”, ha spiegato. Insomma, un cambio di passo, nei numeri e nei fatti, che dovrà proseguire nel tempo, per preservare le caratteristiche pressoché uniche al mondo di equità e universalità del Servizio Sanitario Nazionale. Un obiettivo condiviso a pieno da Assidai, che considera la sanità pubblica come pilastro irrinunciabile per il Paese. Allo stesso tempo, il nostro Fondo, che ha natura di fondo sanitario non profit, si propone come possibile supporto al Servizio Sanitario Nazionale, sempre più alle prese con l’invecchiamento della popolazione e con il conseguente aumento delle cronicità e della spesa.
La svolta del Piano operativo nazionale
Un aspetto rilevante, evidenziato dal Ministro Speranza, è quello del Pon salute (Piano operativo nazionale), che quest’anno ci sarà per la prima volta in assoluto. “Nella lunga storia della programmazione delle risorse europee, i Pon sono sempre stati uno strumento fondamentale per ridurre le diseguaglianze tra Sud e Nord e si è fatto il Pon quasi su tutto, ma mai sulla salute. Questa volta, grazie al nostro impegno, portiamo a casa un risultato senza precedenti: 625 milioni per il Pon salute”, ha fatto notare il Ministro, sottolineando che questi capitali verranno usati “per recuperare i ritardi sugli screening oncologici, che al Sud sono maggiori rispetto al resto d’Italia, sulla salute mentale, che è un grandissimo tema del futuro, sui consultori e sulla medicina di genere”.
Le tre parole chiave per il futuro
Prossimità, innovazione ed uguaglianza. Sono queste le tre parole chiave attorno alle quali Speranza immagina la sanità del futuro in base alla riforma messa in campo con il Pnrr e che investe circa 20 miliardi. La prossimità è l’idea di un Servizio sanitario nazionale più vicino ai cittadini, il cui primo elemento è l’assistenza domiciliare, tema ancora debole e fragile. Fino a pochi mesi fa il 4% delle persone sopra i 65 anni poteva avere un medico o infermiere che si recava alla sua abitazione. La media dei paesi Ocse è il 6%, Germania e Svezia, i migliori esempi in Europa, sono al 9%. “Con le risorse del Pnrr l’Italia diventerà il primo Paese d’Europa per assistenza domiciliare con il 10%: passeremo dunque da paese al di sotto di due punti della media Ocse ad essere quattro punti sopra”, ha promesso Speranza.
La seconda parola chiave è innovazione, perché – ha aggiunto – “una sfida del futuro è quella della sanità digitale. Ormai la telemedicina, la tele-assistenza, il fascicolo sanitario elettronico sono punti fondamentali di un’agenda che dobbiamo definire e costruire con coraggio”. Quindi, “dobbiamo investire sulle reti informatiche e usare meglio i dati, patrimonio senza precedenti a nostra disposizione. E i dati, in sanità, sono particolarmente significativi, perché ci possono dire dove stanno andando il nostro Paese e la nostra regione. Con i dati si possono costruire modelli predittivi che ci possono far capire sul piano epidemiologico quali sono i punti su cui dobbiamo mettere più risorse”.
Infine, la terza parola, forse la più importante, è uguaglianza. “Provare a costruire una sanità di tutti, perché il diritto alla salute è un diritto universale che va difeso con il coltello tra i denti. Nascere in una piccola provincia non deve dare meno diritti di chi nasce nei grandissimi centri delle città più importanti del nostro Paese. Questo dice la Costituzione e a questo dobbiamo lavorare incessantemente”, ha concluso il Ministro della Salute.
Dove si investirà grazie al Pnrr
Il Pnrr rappresenterà, quindi, un elemento cruciale per potenziare gli investimenti sulla sanità pubblica e migliorare le sue capacità di risposta ai bisogni di cura dei cittadini, anche alla luce delle criticità che la pandemia ha messo in evidenza negli ultimi mesi. Con i 20 miliardi circa che arriveranno dal piano europeo si agirà principalmente in due direzioni. Da una parte si lavorerà sulle Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, alle quali sarà dedicata una dotazione complessiva di circa 9 miliardi. L’altra grande direzione in cui opererà il Pnrr è quella legata a innovazione, ricerca e digitalizzazione, che avrà un budget vicino agli 11 miliardi. Una buona fetta (4 miliardi) sarà destinata all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, ad esempio con l’acquisto di strumentazioni e tecnologie all’avanguardia e con il rinnovamento della dotazione esistente di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. Oltre 1,6 miliardi, di cui 1 miliardo relativo a progetti già in essere, saranno finalizzati all’adeguamento antisismico degli ospedali.